A trent'anni dalla prima pubblicazione de L'ordine senza piano, il pensiero di Lorenzo Infantino è ancora attuale
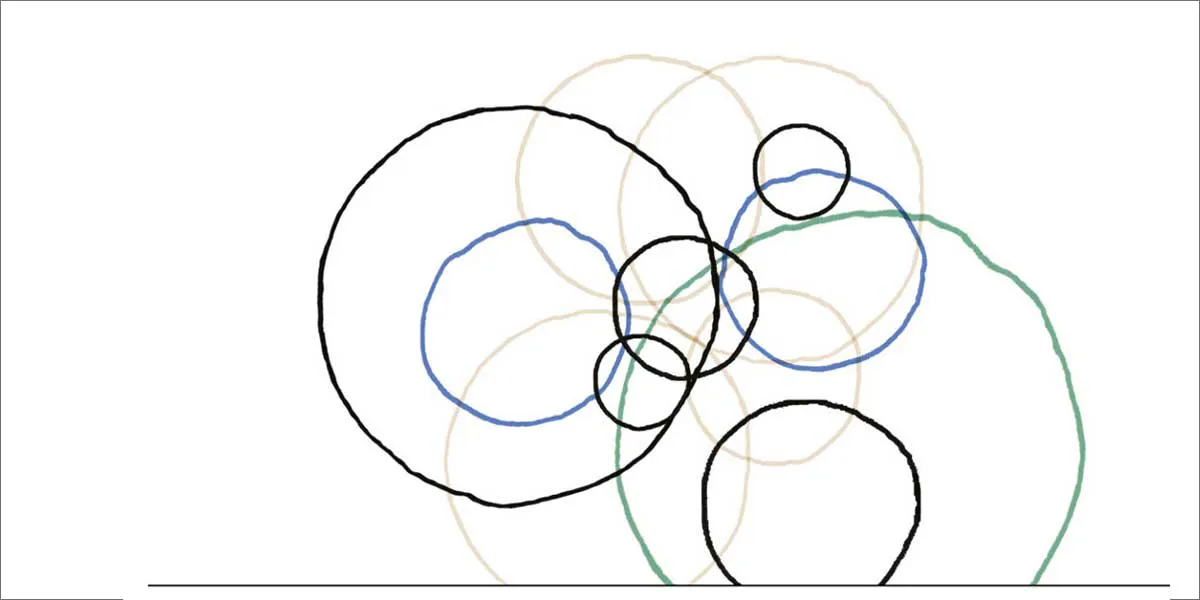
25 Febbraio 2025
La Provincia
Alberto Mingardi
Direttore Generale
Argomenti / Teoria e scienze sociali
Come può esserci un “ordine” in assenza di un piano, di un principio o di un agente, per l’appunto, “ordinatore”? Per la gran parte, la nostra vita quotidiana si svolge senza che nessuno l’abbia progettata nel dettaglio.
Le nostre città hanno un piano regolatore, che stabilisce alcune delle caratteristiche che debbono avere i suoi edifici e influisce anche sulla vita economica, indicando per esempio che alcune attività possono espletarsi in determinati luoghi e non in altri. Ma non c’è piano che determini quanti sfilatini e quante baguette devono essere sfornate tutti i giorni dai panifici, o di preciso quante verdure d’un tipo o d’un altro debbano vendere gli ortolani, e nemmeno quali e quanti tagli di carne debbano trovarsi in macelleria.
Eppure, ogni santo giorno, milioni di persone trovano in ciascuno di questi esercizi più o meno quello che desiderano, secondo le proprie possibilità, e riescono a nutrirsi decentemente. L’italiano che parliamo e scriviamo tutti i giorni è debitore ad Alessandro Manzoni e al maestro Manzi, ma è parlato e scritto, appunto, da milioni di persone, buona parte delle quali non ha mai letto l’uno e non serba neanche un vago ricordo dell’altro. La lingua si ostina a cambiare.
L’Accademia della Crusca si affretta a biasimare certe evoluzioni che lasciano perplessi gli studiosi. Eppure se la gente comincia a usare “piuttosto che” come “oltre che”, o a considerare “tariffa” un rinomi di “dazio”, o a usare a ogni pie’ sospinto aggettivi obbrobriosi come “sfidante”, c’è poco da fare. La lingua è dei parlanti e serve per capirsi, non per fare sfoggio di buona cultura.
Due modi
Ne L’ordine senza piano, pubblicato per la prima volta trent’anni fa, tradotto in inglese e spagnolo, ora ripubblicato da Rubbettino, Lorenzo Infantino cercava di esplorare la tradizione delle scienze sociali che ha provato a dar conto di fenomeni di questo tipo. Per lui, i modi di guardare la società sono essenzialmente due: il “collettivismo metodologico” e l’“individualismo metodologico”.
Le parole possono ingannare. Nonostante si chiami “collettivismo”, “il primo si affida a un gruppo ristretto di individui, che vengono sottratti, attraverso il conferimento di una conoscenza superiore, a ogni limite e a ogni controllo”. Il secondo, al contrario, tende a sottolineare i limiti di ogni singolo individuo. Le nostre facoltà cognitive ci inibiscono la possibilità di progettare davvero qualcosa di più grande delle nostre scelte di vita. I fenomeni sociali hanno troppe variabili e non riusciamo a tenerli sotto controllo, non sono replicabili in laboratorio, non sempre il battito d’ali di una farfalla in Brasile causa un terremoto in Giappone ma le azioni dei singoli riverberano oltre le loro intenzioni.
L’individualista metodologico, versione Infantino, vede nell’ordine sostanzialmente la conseguenza inintenzionale delle azioni degli individui. In un supermercato, c’è qualcuno che appiccica i cartellini dei prezzi sui singoli prodotti in vendita. Ma quelle cifre ogni tanto cambiano, a seconda del fatto che le merci in questione siano più o meno richieste. Con l’eccezione di qualche caso rarissimo (per esempio un boicottaggio), non è che gli acquirenti ne comprino di più o di meno a comando.
Quando spingiamo il carrello della spesa, ognuno di noi pensa alle sue necessità. I prezzi si alzano quando un bene è molto domandato, si abbassano quando il negozio deve smaltire le scorte. Non è la passione per la “sostenibilità” che spinge i supermercati a vendere a prezzo ribassato lo yogurt di imminente scadenza, quanto la preferenza per un profitto minore rispetto al perdere quattrini.
Pensatori
C’è una famiglia di pensatori politici che si è resa conto di come i gruppi umani riescano a correggere la propria rotta senza che nessuno ne regga il timone. Montesquieu osserva che “ognuno promuove il bene comune, credendo di promuovere solamente i propri interessi”. Hume scrive che ciascuno “avvantaggia il pubblico, anche se non è quello lo scopo perseguito”. In epoca moderna, Thomas Hobbes aveva già spiegato che il concetto di “interesse” poteva offrire un fondamento all’ordine sociale più solido di altri. Ma Hobbes si aspettava che degli individui autointeressati si mettessero d’accordo, o proponeva di paragonare un dato ordine sociale a quello che sarebbe sortito da un loro, eventuale, esplicito accordo.
Cinquantaquattro anni dopo “Il Leviatano”, un medico olandese trapiantato a Londra, Bernard de Mandeville, suggerisce con un poemetto di 400 versi (e abbondanti pagine a commento) che un alveare felice possa sortire da comportamenti meno che virtuosi delle singole api. La questione non è che i vizi privati abbiano per esito le virtù pubbliche, ma che non c’è corrispondenza immediata e sicura fra virtù o vizi privati e conseguenze collettive. Ci sono più cose in cielo e in terra di quante possa spiegarne una filosofia rassicurante.
L’ordine senza piano è il libro più bello di Lorenzo Infantino, che ha dedicato tutta la sua carriera a esplorare e raccontare quella famiglia di pensatori che va da Mandeville a Friedrich von Hayek. A Infantino si devono importanti traduzioni della scuola austriaca dell’economia, in particolare modo delle opere maggiori di Ludwig von Mises.
Nei suoi lavori, Infantino ha dato corpo alle indicazioni offerte da Hayek sulla genealogia del proprio pensiero. Ne viene fuori l’album di una famiglia irriverente. Oggetto della loro iconoclastia è il santino che gli umani fanno della propria ragione, alla quale si aggrappano per convincersi che il mondo somigli al suo progetto.
Infantino, morto a 77 anni lo scorso 18 gennaio, ammoniva di non cercare nella realtà conferme ai nostri desideri e invece di imparare a meravigliarci dei risultati imprevisti della cooperazione umana. Quando L’ordine senza piano vedeva la luce, anche in Italia si stava facendo largo l’idea che se si doveva diffidare dei politici come pianificatori della società, forse ci si poteva affidare a degli economisti, tecnici di provata esperienza. Per lo studioso calabrese, a lungo professore di metodologia delle scienze sociali alla Luiss, “l’individuo e la società si trovano in una condizione di permanente disequilibrio; le preferenze sono sottoposte a un processo di incessante mutamento” e non si sa che cosa di preciso debba essere “massimizzato”.
La conoscenza dei tecnici è limitata come quella di tutti gli altri, per quanti “modelli” possano mettere a punto. In un Impero in cui l’arte della cartografia raggiunge la perfezione, l’unica mappa pienamente soddisfacente è quella che eguaglia in grandezza l’Impero e coincide puntualmente con esso, come scriveva Borges.