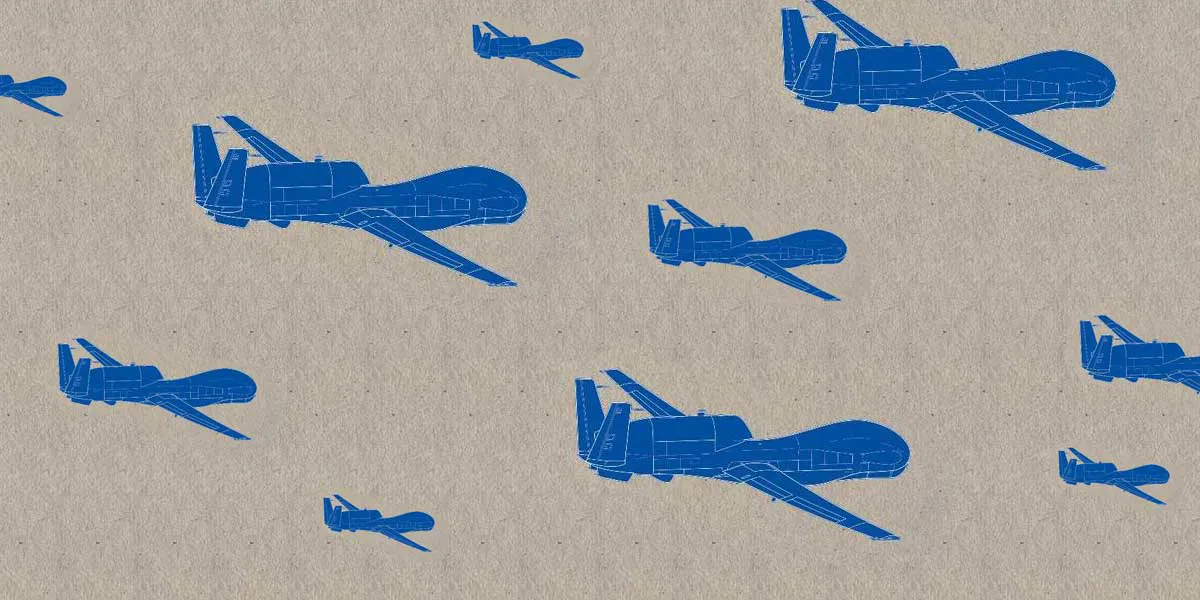
Se la guerra è tornata, come titolano i primi capitoli di Capitalismo di guerra (Fuoriscena, pp. 219), è tornata anche la sua economia. Quella che i manuali di storia descrivono come eccezione drammatica, e che invece oggi — secondo Alberto Saravalle e Carlo Stagnaro, coppia collaudata: giurista uno, economista l’altro — rischia di diventare la nuova normalità.
Titolo forte, tesi altrettanto: la logica del conflitto, un tempo relegata al dominio della geopolitica e delle armi, si è infiltrata nei meccanismi del mercato globale, nei flussi di investimento e persino nel diritto. Il saggio, non a caso, si apre con una notizia: un contratto di acquisizione, concluso tra due delle principali società italiane, nel quale compare in bella vista «una clausola che consente il recesso se scoppia un conflitto che possa coinvolgere il nostro Paese (il riferimento è proprio all’articolo 5 del Trattato Nato)». Contratto vero, siglato nella primavera 2024. «D’altronde, che siamo a rischio di guerra, quella vera, belligerante, non solo economica, non lo diciamo noi — sottolineano gli autori —, ma lo dicono Ursula von der Leyen e Charles Michel».
Per chi ha vissuto l’epoca dell’ottimismo globalista — vedi la «fine della storia» di Fukuyama — il libro è un brusco risveglio. Ma non è un pamphlet ideologico, né un atto di nostalgia (le guerre economiche esistono dai tempi di Pericle). Saravalle e Stagnaro mettono in fila dati, decisioni, passaggi legislativi. L’impressione è di un mondo che ha rotto con i suoi dogmi recenti senza averne elaborati di nuovi. L’analogia più ricorrente nel libro è quella con il Risiko. Le scelte dei governi — scrivono gli autori — si fondano oggi su una logica reattiva, pan per focaccia, che ricalca la dinamica del gioco da tavolo. Il problema è che questo meccanismo produce l’effetto opposto: «Creando barriere, restrizioni, dazi, alimentiamo un circolo vizioso. I timori di guerra generano politiche aggressive che aumentano la conflittualità. E il passo dalla guerra economica a quella armata può essere breve». I dazi, in questo senso, sono solo la punta dell’iceberg. «Le guerre tariffarie danneggiano tutti, in primis coloro che le avviano».
Il libro attraversa tutti i campi di battaglia contemporanei. Commercio, dati («gli Stati Uniti puntano sul mercato, la Cina li usa per sorvegliare i cittadini, l’Europa favorisce la tutela degli utenti ma così rallenta l’innovazione»), energia, intelligenza artificiale («AI nationalism»), chip («Qui la guerra è iniziata nel 2019, quando Trump ha posto restrizioni a Huawei»). Il linguaggio è cambiato: si parla di «weaponization». «Tutto può essere utilizzato impropriamente — notano — il mercato, la valuta, persino la corruzione».
Già, ma cosa fare allora? Nessuna formula magica, ma alcune strade: «Rafforzare le alleanze commerciali alternative, rilanciare l’unione dei capitali, rimuovere ostacoli interni agli investimenti privati». E soprattutto «mutare la narrazione prevalente: smettere di accettare che l’autarchia sia l’unica forma di sicurezza — chiudono Saravalle e Stagnaro —, riscoprendo che l’apertura può ancora essere una forza».